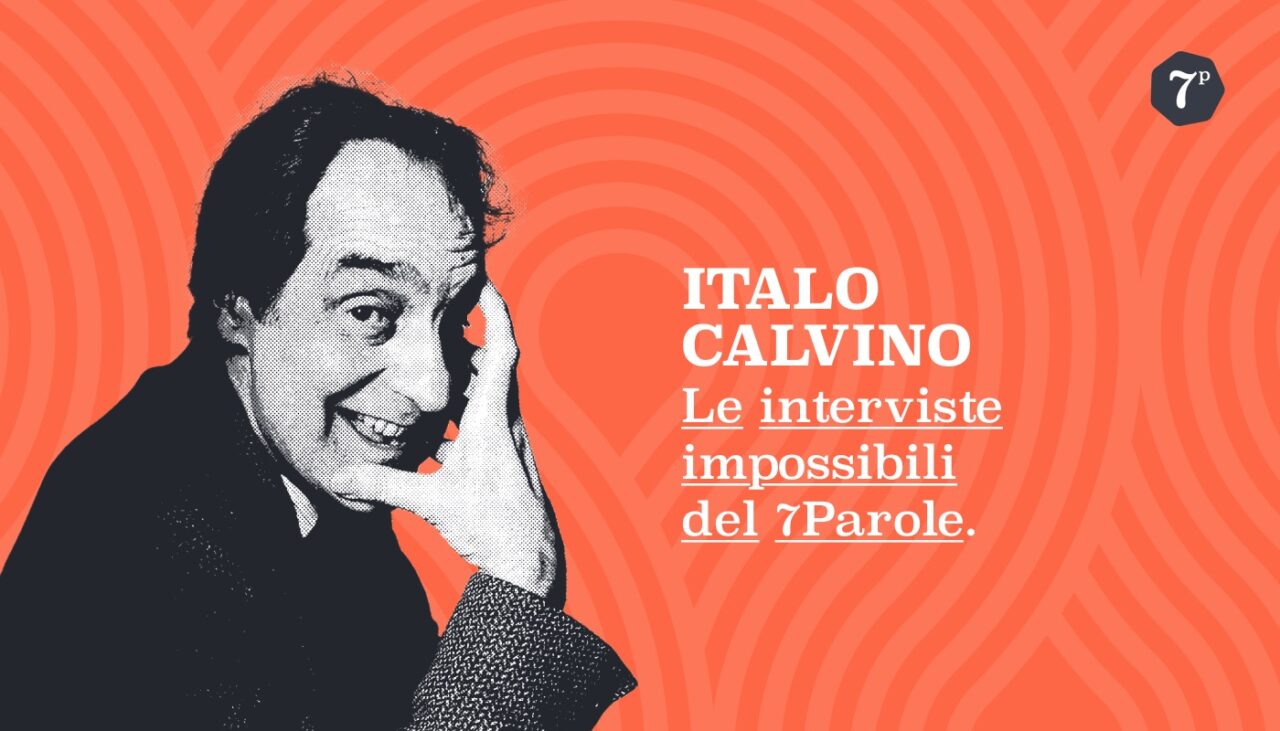Possiamo farle una domanda, Italo? Anzi, 7
Abbiamo scomodato Italo Calvino per questa nostra prima intervista impossibile. Lui è stato al gioco, e gliene siamo grati. Non è da tutti, anzi: è solo dei maggiori. A voi lettori raccomandiamo di accogliere con benevolenza questa nostra piccola impresa, mica siamo bravi come Arbasino o Manganelli, per tacer di Umberto Eco e dello stesso Calvino. Insomma: siate indulgenti con noi, che ci abbiamo messo il cuore.
Caro Italo, oggi abbiamo ancora città invisibili?
Le mie città invisibili sono fatte di immagini e parole, esistono grazie a quelle immagini e parole. Sono dunque invisibili e visibili allo stesso tempo. Le vostre città sono fatte di numeri, di dati, nascono nel segno della rete, o forse meglio, della prestazione. Ma le città, proprio come la memoria, non sono riducibili ai dati contenuti in un hard disk. Per esistere davvero, una città deve essere raccontata.
E che combinerebbe oggi un novello Marcovaldo?
E chi lo sa? Marcovaldo è figlio del suo tempo. Un figlio sghembo, certo, ma altrettanto puro. Come ha scritto Maria Corti, «lui vede quello che gli altri non vedono e non vede quello che gli altri vedono». E se è vero che ogni sua iniziativa finisce con una sconfitta, Marcovaldo non è certo uno che si arrende. Non per chissà quale spirito rivoluzionario, no. Direi per indole.
Ecco, oggi Marcovaldo forse sarebbe un resistente naturale, un’anima bella che va in cerca di qualche traccia di meraviglia e gioia. Diciamo pure di vita. E se oggi tutti vivono in attesa, non si sa bene di che cosa, Marcovaldo predilige e pratica la sorpresa.

Oggi siamo divisi. Come il suo Visconte…
Ha ragione, sì. Ma il mio Visconte è diviso in due perché ambisce a essere un intero. Sa, per come la vedo io, voi siete composti da frammenti che non dialogano tra loro. Questa molteplicità non esprime ricchezza, ma povertà, proprio come la brevità sciocca di cui ho parlato prima. Questa divisione dell’io mi pare la cifra più esatta dell’identità, che si fa culto del frammento, della porzione, della scheggia. Sa che cosa siete diventati? Dei coltellini svizzeri. Ottimi per mille usi, funzionali a molteplici imprese, pronti a risolvere ogni problema. Eppure, se vi guardate intorno, tutto va a rotoli, o perlomeno arranca. E il conto non torna.
La forma breve è limitazione o evoluzione?
Non è la lunghezza di una storia che conta, ma la sua densità, la sua forza espressiva. Chi scrive, lavora a togliere, sempre. Io ho cercato la brevità per contenere l’universo in una pagina, l’infinito in una riga. Ho persino vagheggiato di dar vita a un’antologia di racconti brevi, anzi brevissimi, di una riga soltanto. Proprio come il testo di Augusto Monterroso che giustamente ponete in esergo al vostro progetto.
Ma se guardo ai nostri giorni, o per meglio dire ai vostri, temo che la Rapidità – la chiamo così nelle mie Lezioni – sia una condizione, anzi una costrizione, e non frutto di una ricerca. Questa forma di brevità è un punto di partenza, una condizione, addirittura un inciampo: non si è in grado di andare oltre perché mancano le parole, o se preferisce, il coraggio; la vera brevità è un punto di arrivo, grazie alla fatica – mi consenta questo termine – con la quale rimuoviamo il superfluo per dar vita all’essenziale.
In particolare, vedo che vi affidate a macchine e strumenti sempre più potenti, che distillano risposte alla velocità della luce. Mi viene in mente un duello all’alba tra due pistoleri, chi estrae l’arma per primo vince. La mia epoca ambiva alla profondità e amava la leggerezza. La vostra chiede soluzioni rapide e facili da maneggiare. E ha la pistola facile.
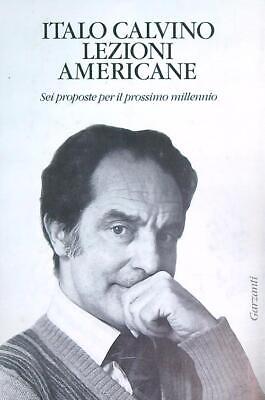
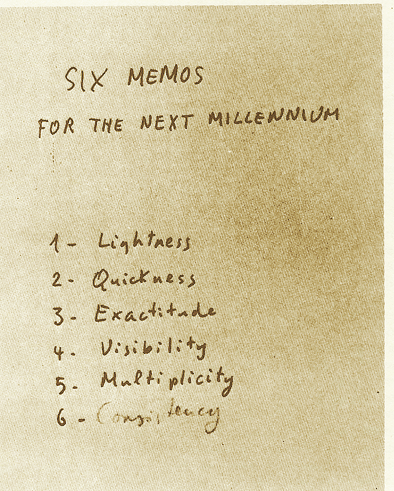
Per lei la scrittura è arte combinatoria?
In un certo senso, sì: scrivere significa disporre dei temi in sequenza. O per meglio dire: lasciarsi guidare da quei temi che si aggregano e dispongono in un intreccio narrativo. Io l’ho fatto con i tarocchi, come saprà. Ogni carta mi suggeriva una situazione, ma solo la carta vicina consentiva lo svolgimento, il seguito della storia. Ma sa qual era la cosa più avvincente? Il caso guidava la disposizione delle carte, e dunque la matrice stessa della storia.
Ecco: il racconto era figlio del caso e, in un certo senso, si narrava da solo. A me pare che in questo modo la scrittura sia emblema del reale. È mimetica, o meglio: è simile ai radar altimetrici che consentono agli aerei di mantenere una distanza costante dal suolo. Questa immagine è di Daniele Del Giudice, mi piace ricordarlo qui.
Che mi dice del futuro del libro?
La forma-libro potrà certamente evolversi, potrà persino scomparire, ma le storie no. Noi uomini avremo sempre bisogno di storie, perché senza racconto non c’è realtà. Vede, non è la realtà che offre materia alla narrazione, ma la narrazione che ci consente di comprendere la realtà. Mi permetta una citazione: «La gobba dell’onda venendo avanti s’alza in un punto più che altrove ed è di lì che comincia a rimboccarsi di bianco».
Qui Palomar osserva un’onda, si ostina a cogliere proprio quella; ma le onde s’inciampano tra loro, quella singola onda si confonde e l’intento si perde. Eppure lui non demorde: ci insegna la dedizione necessaria al processo conoscitivo, e cognitivo in genere. In questo resistere ricorda un po’ Marcovaldo, forse tutti i miei personaggi sono macchine malinconiche. Forse sono dolcemente nichilisti, che ne dice?
Ma lei mi aveva chiesto del libro: il libro è una conchiglia che racchiude la melodia del mare. Non sai come accade ma, proprio perché non riesci a spiegarti l’arcano, ogni volta l’incanto ti sorprende e sprona. Se mi guardo intorno ho il timore che oggi vogliate costringere il mare in una bottiglia, o ridurlo a desiderio minore. Non è la stessa cosa.
Consigli per un giovane scrittore di oggi?
Trovare il proprio universo narrativo in ogni minima cosa: una certa parola, quello sguardo smarrito, il pulviscolo che danza in un raggio di sole. Se non sai raccontare l’infinitamente piccolo come puoi pretendere di raccontare il mondo?
Grazie infinite, Italo. Per la colonna sonora ho pensato a La Guerra di Piero di Fabrizio De Andrè: vuoi perché è sempre più attuale, vuoi perché deve più di qualcosa a una canzone da lei scritta una decina d’anni prima, Dove vola l’avvoltoio?
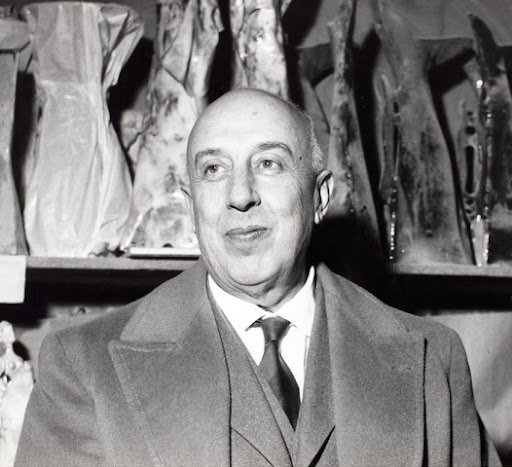
Claudio Calzana
Altri articoli
-

È andata così, parola di Vitello Grasso
Bentrovato signor Vitello Grasso, e grazie per… Grasso un corno! Che poi anche su Vitello avrei da ridire, mi mancava qualche giorno per diventare Manzo, ti rendi conto? Se proprio proprio Vitellone, allora. E poi, […]Leggi l'articolo -

Il poeta è l’irriducibile per definizione
Le indicazioni erano a dir poco sommarie: «Lo puoi trovare là dove la città finisce e qualcos’altro non è ancora cominciato». Grazie tante, ho pensato. Mi son messo a vagabondare ai margini di Roma, con […]Leggi l'articolo