Il poeta è l’irriducibile per definizione
Le indicazioni erano a dir poco sommarie: «Lo puoi trovare là dove la città finisce e qualcos’altro non è ancora cominciato». Grazie tante, ho pensato. Mi son messo a vagabondare ai margini di Roma, con il dubbio che, anche se l’avessi trovato, difficilmente avrebbe risposto alle mie 7 domande di 7 parole ciascuna. Ho vagato a caso, confidando nel fato, annusando certi luoghi. Verso sera l’ho trovato in un campetto a Primavalle; stava su una panchina malmessa, lo sguardo perso avanti, gli occhiali per mano. Mi son fatto coraggio, ho osato il nome: «Pier Paolo…». Si è infilato le lenti prima di voltarsi. Ha abbozzato un sorriso, che ho preso per un sì. Mi son seduto sul bordo della panca, cercando di occupare una porzione minima di suolo.
Pier Paolo, che pensa dell’Italia odierna?
Lo sguardo basso, il respiro lento. Il poeta si prende qualche secondo prima di parlare.
Proprio perché un tempo è esistita, l’Italia ora non esiste. Ha un corpo stupendo, ma dovunque lo tocchi o lo guardi, vedi, attorcigliate, le spire viscide e nere di un serpente, l’altra Italia. E non puoi certo fare l’amore con un corpo avvolto da un serpente. L’Italia trabocca di fascino e ribrezzo.
Si pizzica i pantaloni con due dita, a dar tormento alla riga. Io sono preso da quella voce insieme morbida e tagliente.
Dove sono oggi i “ragazzi di vita”?
Ma ti sei guardato intorno? Non esistono più. Se oggi volessi rigirare Accattone, non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo neanche lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato sé stessi in quel film. Non troverei più un solo giovane che sapesse dire, con quella voce, quelle battute.
È una mutazione antropologica. Quell’innocenza dolce e disperata non poteva sopravvivere in un mondo dove tutto è consumo e la miseria è spettacolo. La miseria, la fame, la morte, il dolore, tutto è spettacolo osceno. I miei ragazzi rubavano per vivere; oggi si vende l’anima per apparire.
Questo consumo di anima è più grave di quello di suolo. Io vedo solo indifferenza e consumo. E se la libertà sta nel consumo, tutto è meschino. Non vedo più la gioia della trasgressione, della colpa. Dove tutto è lecito, non c’è gioia. E men che meno innocenza, splendore.
Per sconfiggere questa indifferenza bisogna riappropriarsi del sacro in ogni gesto, scelta e azione. Se molte e gravi sono state le colpe della Chiesa nella sua lunga storia di potere, la più grave di tutte sarebbe quella di accettare la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del sacro e del Vangelo.
Sembra provato dal suo stesso dire. Insisto, in cerca di un movente.
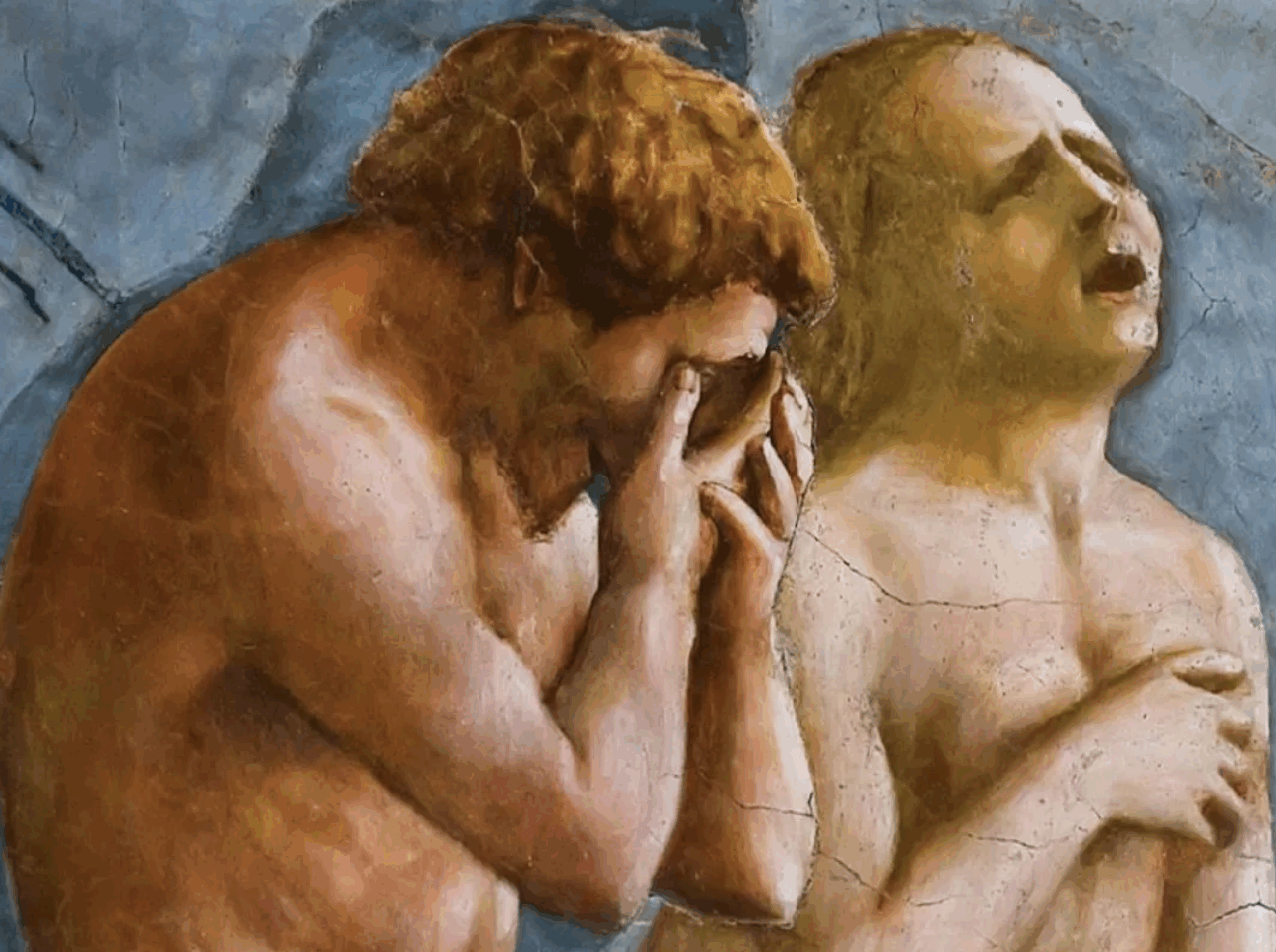
I Sessantottini hanno favorito conformismo e consumismo?
Sì, è proprio così. Hanno creduto di liberarsi dai valori dei padri, ma la loro ribellione è diventata merce. Senza i valori dei padri, il consumismo non ha più avuto freni. Da quel momento la povertà è diventata una colpa, l’essere si è sacrificato all’avere.
Quei ragazzi hanno dettato la fine della differenza, la resa all’omologazione. Gli antichi ribelli sono diventati i nuovi conformisti. Quella rivolta si è fatta moda, potere, pubblicità. Il mio tempo era più facile: di qua i fascisti, di là i partigiani, la differenza era visibile al primo sguardo tanto era incisa nei corpi, in forma di vizio, o di vita.
Alla parola vita disegna qualcosa nell’aria. Provo a sviare, o meglio insisto.
Dobbiamo cercare coerenza in lei, Pier Paolo?
Quanta gioia in questa tua furia di capire! Sarebbe sbagliato non cercare coerenza in me, ma ancor più sbagliato trovarla. Ho sempre cercato lo scandalo del contraddirmi per riuscire a cogliere le contraddizioni del presente.
La mia è niente altro che mimesi. Non bisogna cercare coerenza in me: il pensiero, come il desiderio, vive solo di ferite. Io non voglio essere un simbolo, ma una ferita aperta. E le ferite, si sa, non si celebrano: si evitano.
Mi viene in mente una poesia di Benn, ma evito.
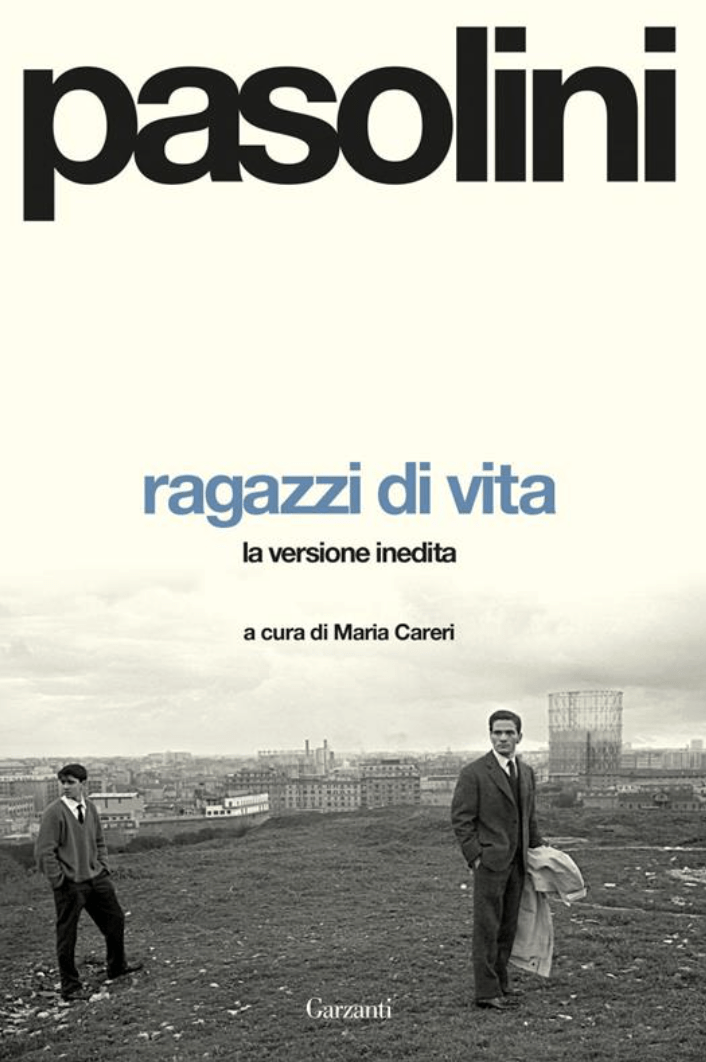
Eppure il suo principio speranza è poetico.
Hai ragione. Non ho mai avuto fede nella storia o nella politica, ma nella poesia sì. E nel sacro, certo. Raboni mi vedeva poeta in tutto tranne che in poesia, e aveva ragione, se per poesia si intende il genere letterario. Io sono poeta in quanto vedo, non in quanto scrivo.
La mia poesia non è questione di metrica o di stile, ma di resistenza; per questo non può essere consolatoria o elegante. La mia poesia non abolisce la disperazione, semmai la circoscrive; non redime, semmai resiste. Il poeta è l’irriducibile per definizione, non salva ma testimonia: e per questo dev’essere feroce.
Mi fissa con uno sguardo muscoloso, non riesco a dirlo meglio. Provo a sfuggire alla presa.
E che ne è della lingua italiana?
La lingua di oggi non rispetta più il corpo della parola, vive solo la sua ombra, nella sua ombra. Tutti si giurano puri: puri nella lingua, naturalmente, segno che l’anima è sporca. L’italiano è stato da tempo annientato dalla televisione, che impone una lingua che sembra l’erba di un giardino senza gramigna: perfetto, cioè morto.
Io scrivo – scrivevo – per restituire alla lingua un po’ di sangue, consapevole che ogni mia frase corrisponde a un funerale. Pensa a quando ho proposto di abolire i luoghi dell’omologazione, televisione e scuola media per cominciare. Anche per questo ero certo che alla mia morte non si sarebbe sentita la mia mancanza. L’ambiguità importa finché è vivo l’Ambiguo. E poi, la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi.
Ora il suo sguardo è perso, lontano. Mi rimane solo una domanda, ne avrei mille.
E allora che resta, solitudine a parte?
Un nuovo indugio in forma di sospiro.
La pietà. Ma quella che nasce dal dolore, non dalla virtù; non quella comoda del paradiso interiore, lì la pietà si fa nemica; non quella dei santi, che assomiglia alla pazienza. Io intendo la pietà dei disperati. La pietà di quando guardi questo mondo con terrore, ma continui a parlargli come a un figlio morto che riposa tra le tue braccia, bagnato di lacrime e grida.
E al momento buono, quando hai le forze giuste, la misura, t’incammini senza fine per le strade povere, dove bisogna saper essere disgraziati e forti, fratelli dei cani.
Capisco dal suo sguardo che è tempo di commiato. Provo a mormorare un grazie, un saluto, ma il poeta mi precede: «Non c’è mai una fine, solo una forma nuova di assenza». Si alza con lentezza, si allontana. Io me ne resto lì, confuso dall’improvviso frastuono del quartiere. Realizzo che non gli ho chiesto della sua Passione. Eppure ne ha parlato, eccome.
Claudio Calzana
4 commenti a questo articolo
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Altri articoli
-

Scrivo per non essere complice del silenzio
Ho bussato alla sua casa natale, a Nuoro, al 42 della via che porta il suo nome. Qualche turista in visita al Museo, un silenzio discreto, ma di lei nessuna traccia per le antiche stanze […]Leggi l'articolo -

È andata così, parola di Vitello Grasso
Bentrovato signor Vitello Grasso, e grazie per… Grasso un corno! Che poi anche su Vitello avrei da ridire, mi mancava qualche giorno per diventare Manzo, ti rendi conto? Se proprio proprio Vitellone, allora. E poi, […]Leggi l'articolo -

Possiamo farle una domanda, Italo? Anzi, 7
Abbiamo scomodato Italo Calvino per questa nostra prima intervista impossibile. Lui è stato al gioco, e gliene siamo grati. Non è da tutti, anzi: è solo dei maggiori. A voi lettori raccomandiamo di accogliere con […]Leggi l'articolo

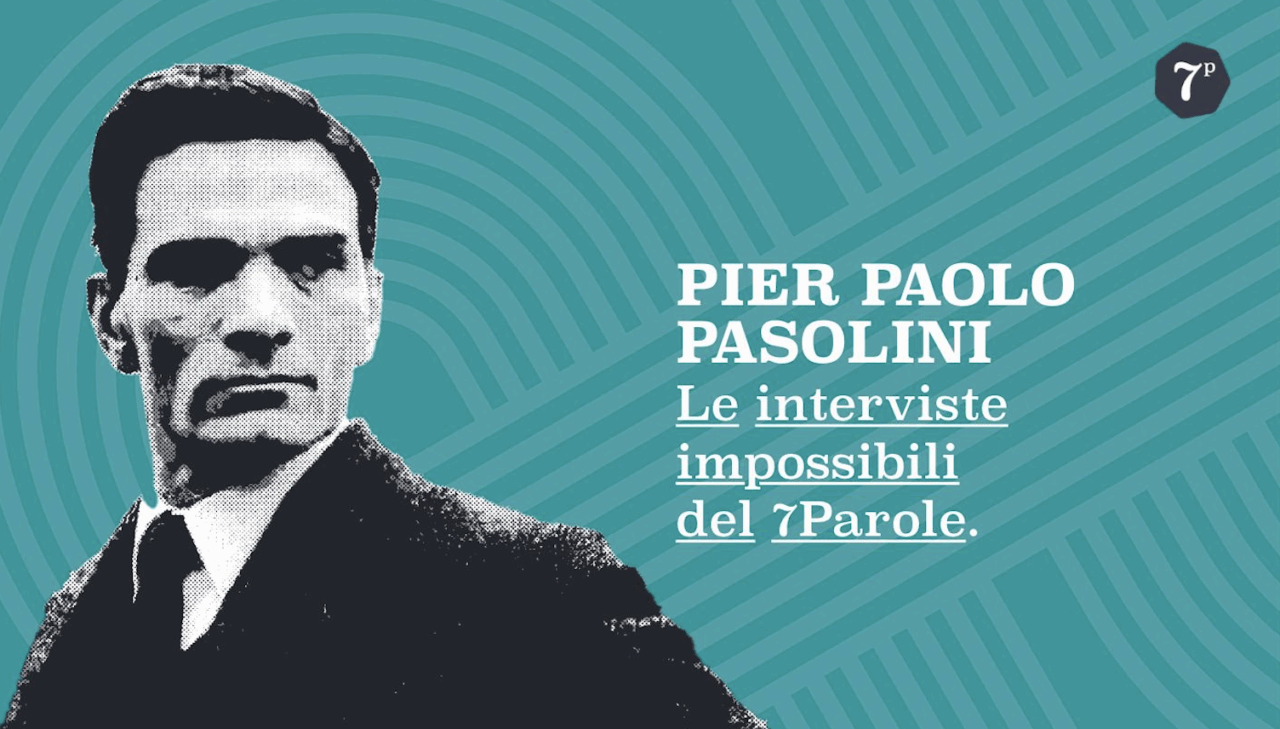



Dove tutto è lecito non c’è gioia..
Le parole in bocca al Poeta sono
sintomatiche, anche la trasgressione
ha perso il suo incanto e per me che
sono del ’48’ tutto questo ha Lasciato
un segno.
L’intervista ha decisamente riacceso
Quel che si andava spegnendo.
Grazie Claudio e complimenti: 7parole
a volte possono essere disarmanti..
Buon 2026.
Roberto
Quando le parole lasciano un segno è decisamente un buon segno. Grazie, Roberto, i tuoi complimenti mi fanno molto piacere, così come quel che scrivi del nostro 7Parole. Buon 2026 a te, nel segno di ciò che ti sta più a cuore. Claudio Calzana
Lucidamente e terribilmente AUTENTICO .
Grazie, Luciana, grazie di cuore.